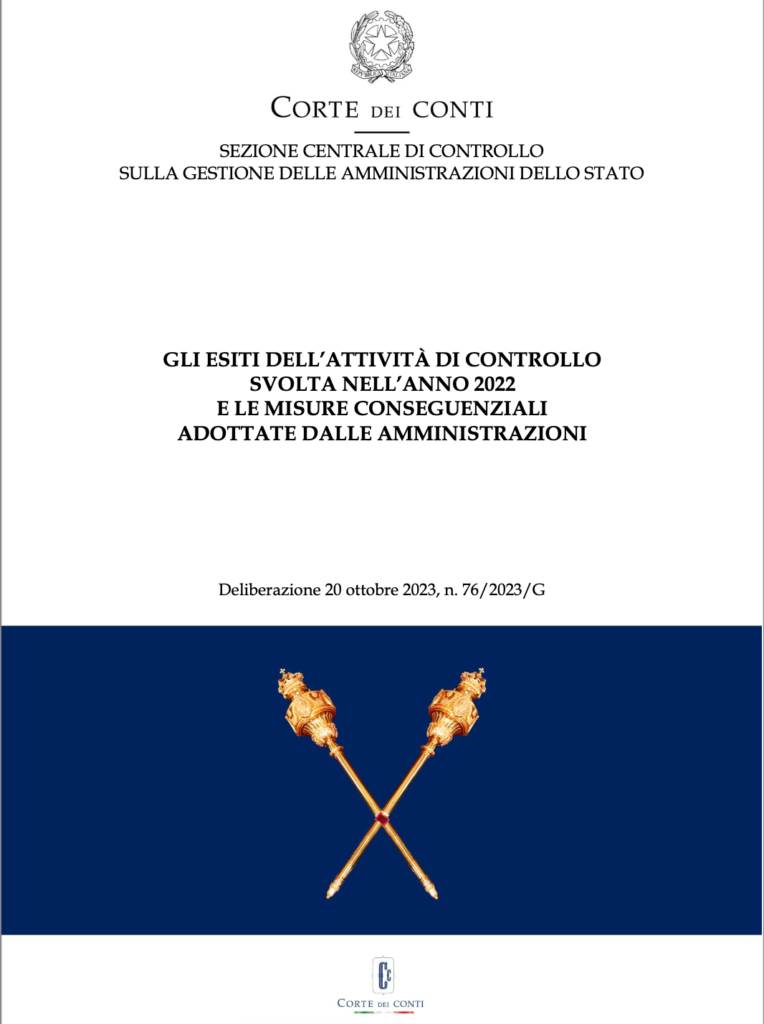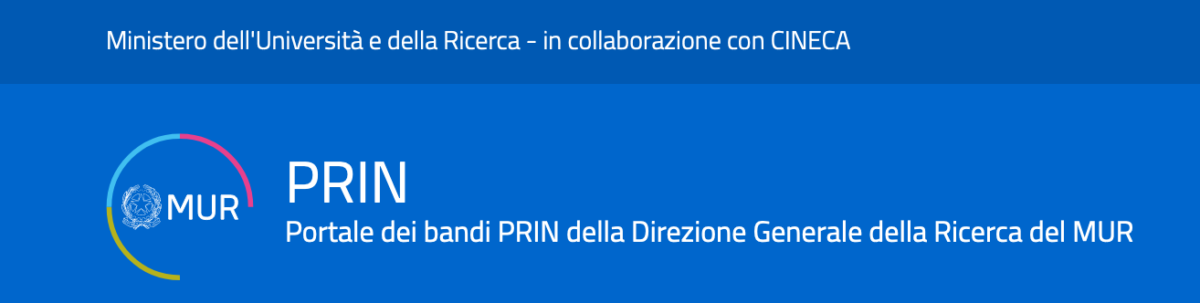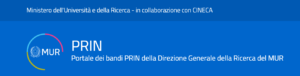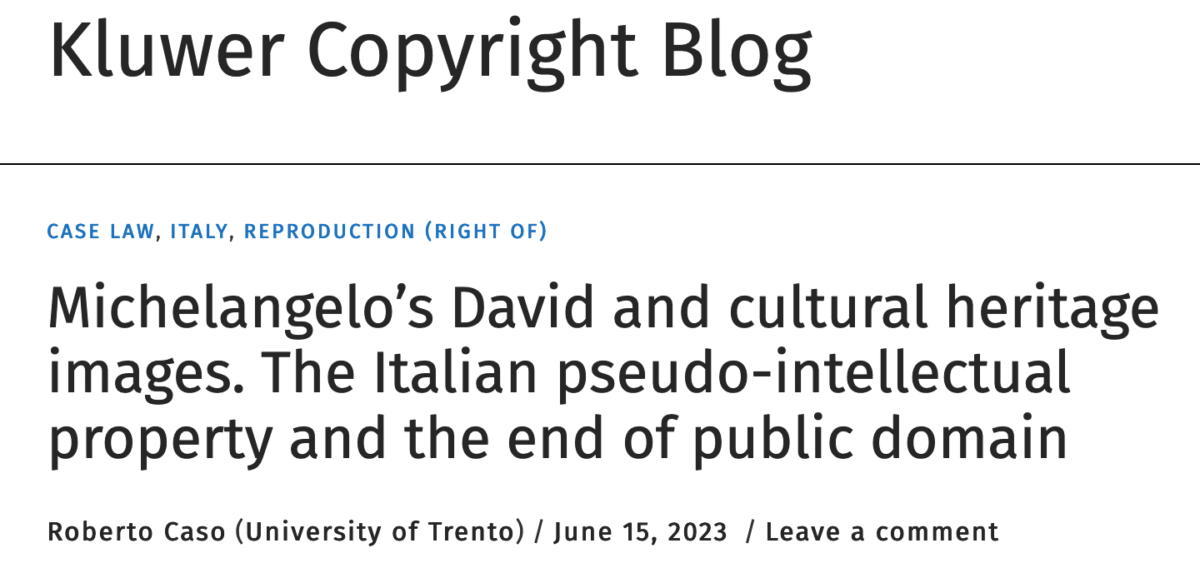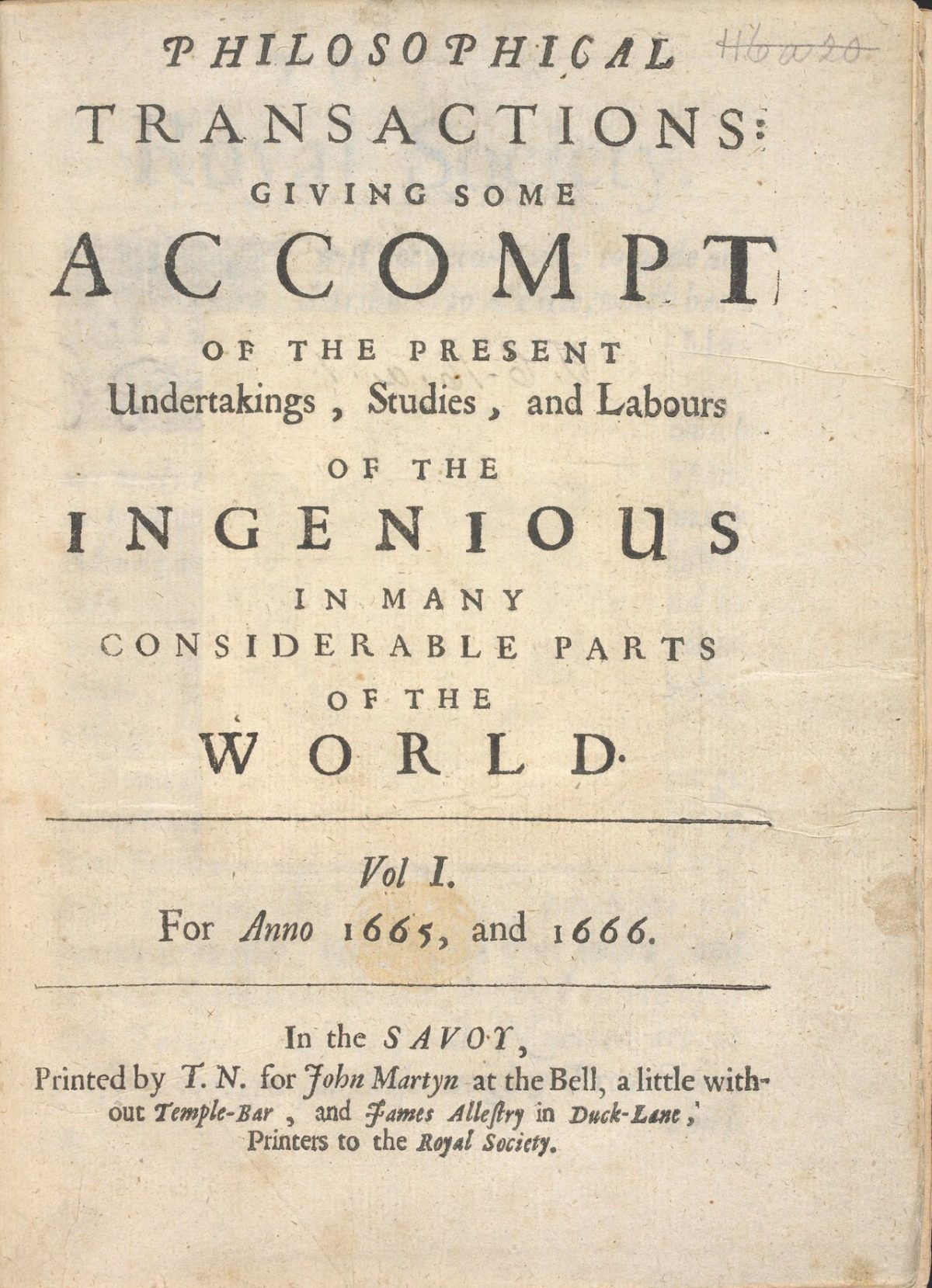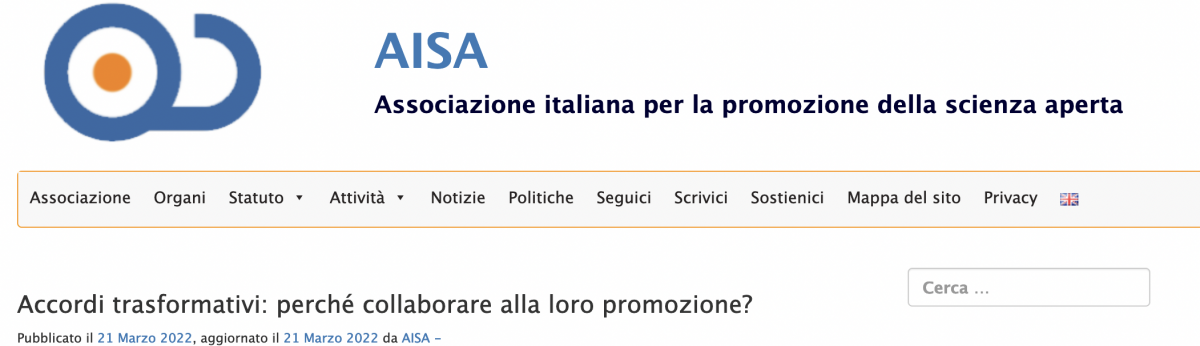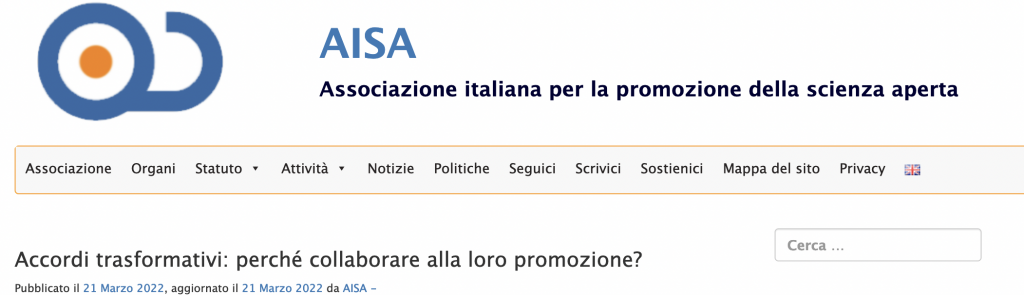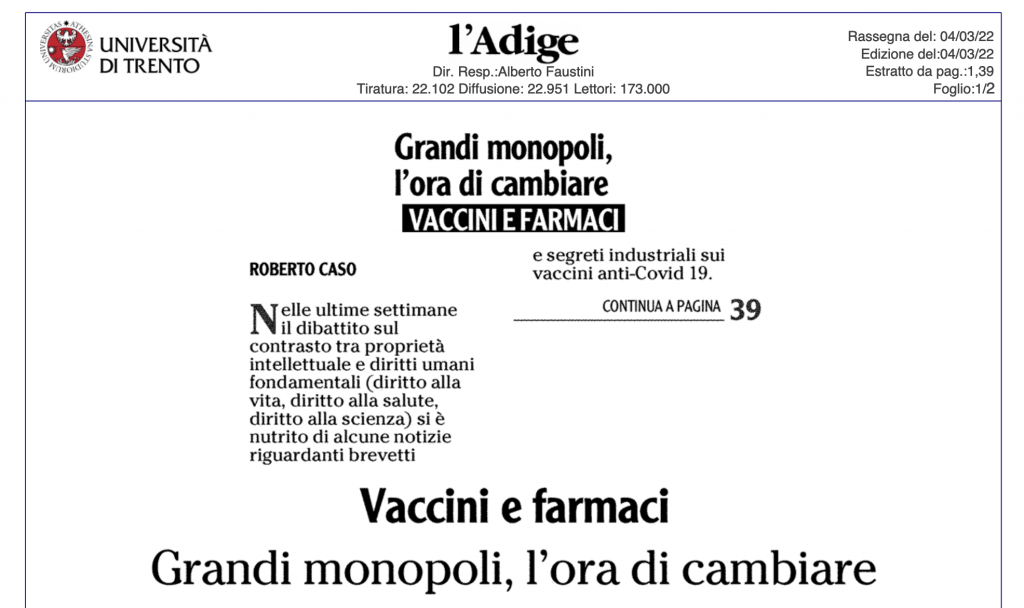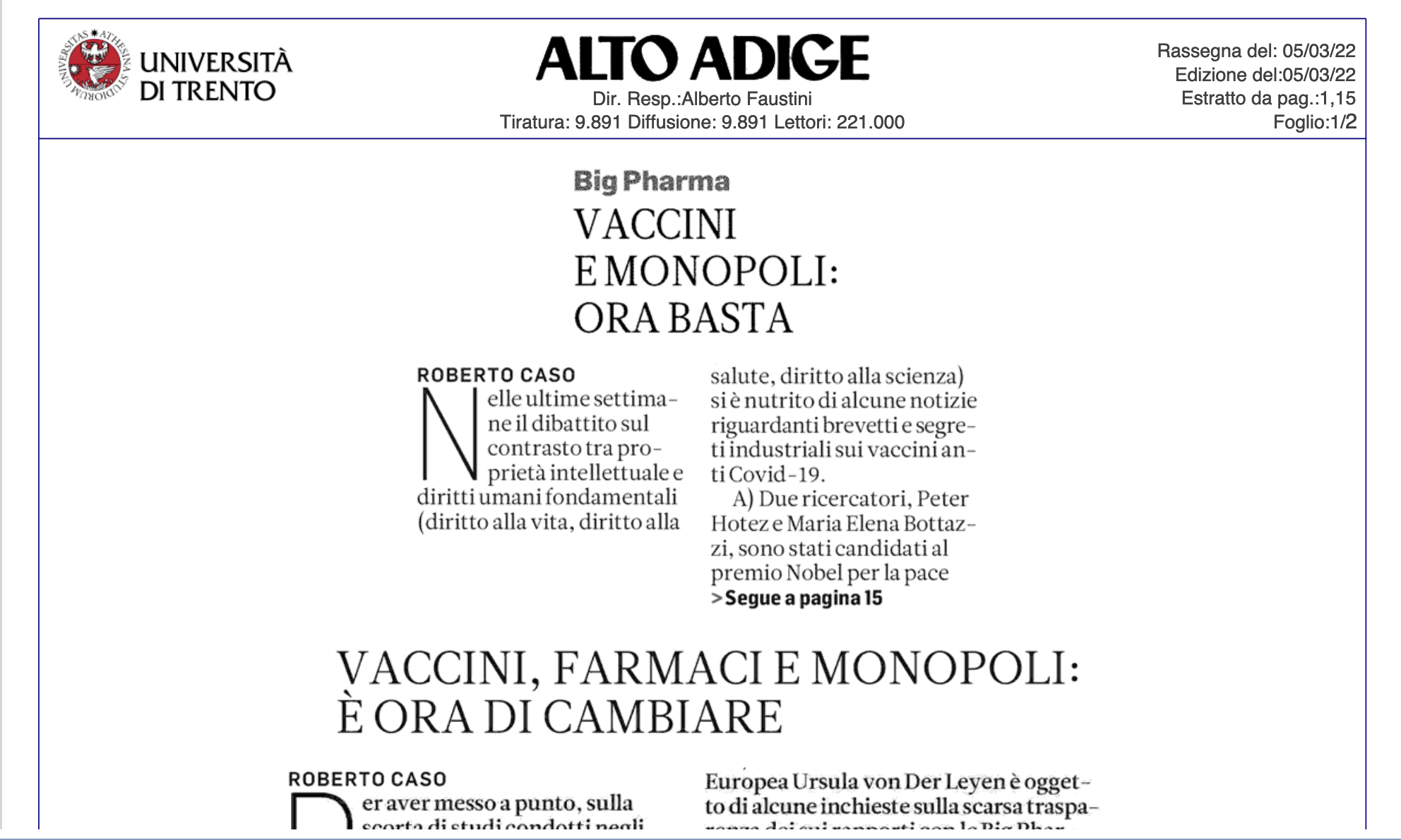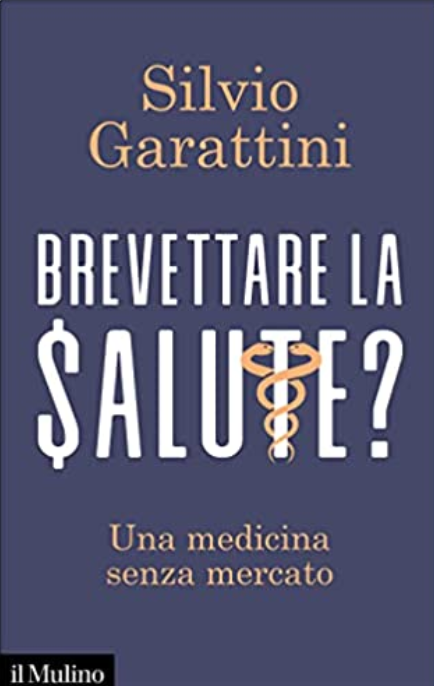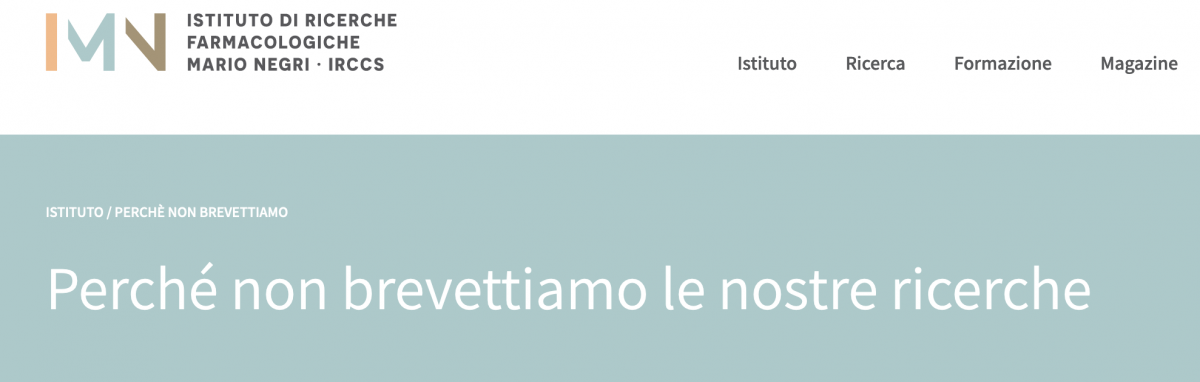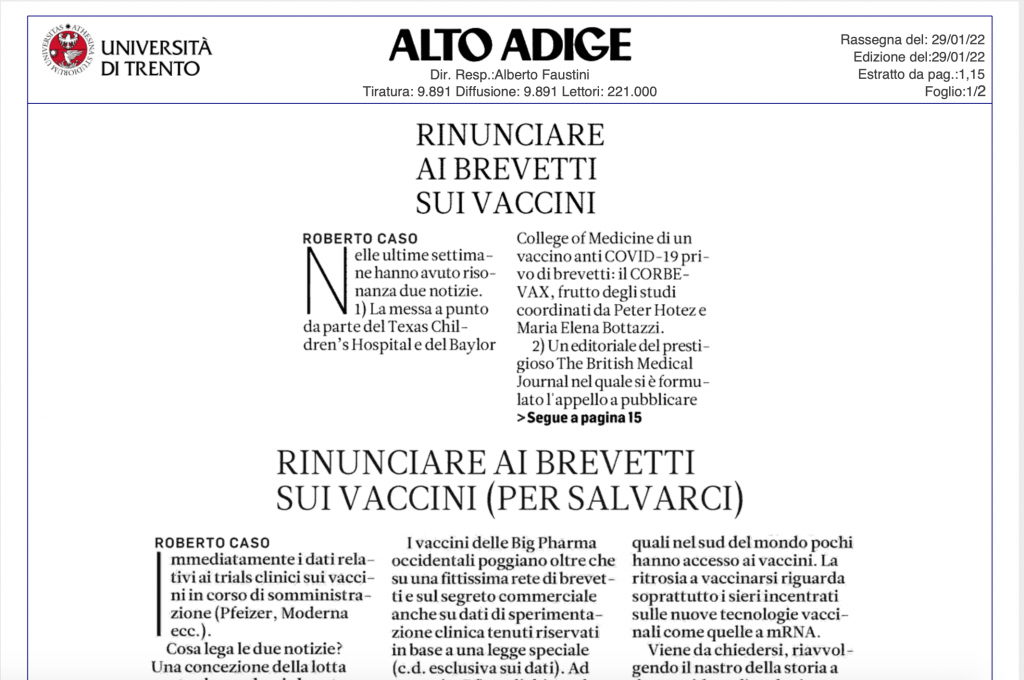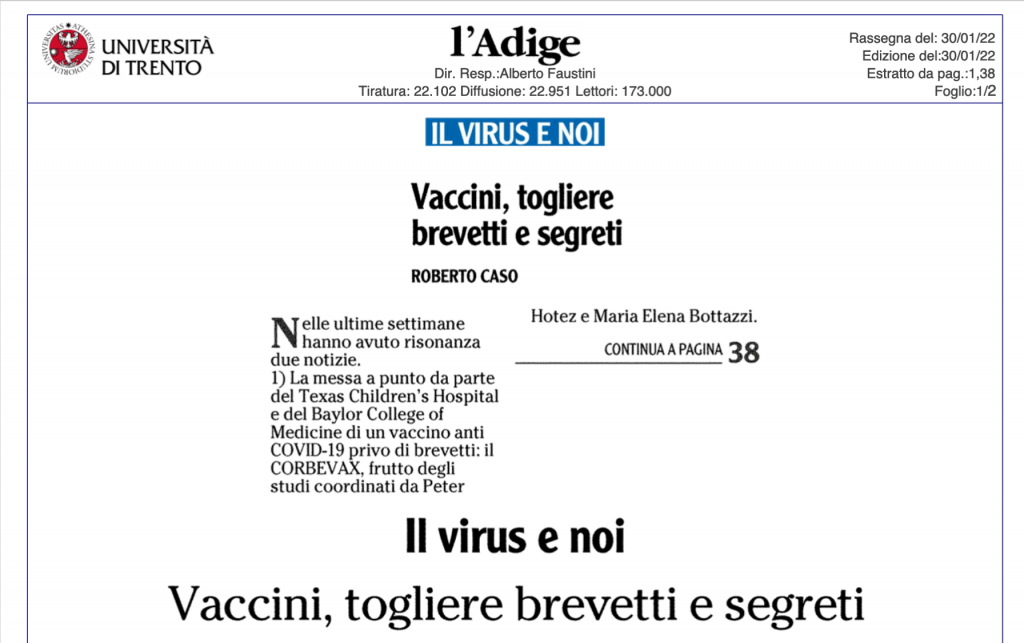Bibliografia
R. Anderson, cOAlition S’s Rights Confiscation Strategy Continues, The Scholarly Kitchen, Jul 20, 2020
P. Attanasio, Punti di vista sull’accesso aperto, in “Giornale italiano di psicologia, Rivista trimestrale” 3/2022, pp. 499-507, doi: 10.1421/105465
M. Baumann, A new copyright law is set to hinder open access, Horizons, 08.03.2018
K.D. Beiter, Reforming Copyright or Toward Another Science? – A More Human Rights-Oriented Approach Under the REBSPA in Constructing a ‘Right to Research’ for Scholarly Publishing (August 15, 2022). Forthcoming in Brooklyn Journal of International Law, Vol. 48, No. 1 (2023), SSRN: https://ssrn.com/abstract=4196341
M. Bellia, V. Moscon, Academic Authors, Copyright and Dissemination of Knowledge: A Comparative Overview (October 28, 2021). Forthcoming in: C. Sappa, E. Bonadio(eds), Art and Literature in Copyright Law: Protecting the Rights of Creators and Managers of Artistic and Literary Works, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, forthcoming, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 21-27, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3970476
K. Bowrey, T. Cochrane, M. Hadley, J. McKeough, K. Pappalardo, K. Weatherall, (2023). Managing Ownership of Copyright in Research Publications to Increase the Public Benefits from Research. Federal Law Review, 0(0). https://doi.org/10.1177/0067205X231213676
J. Cabay, Copyright and Scientific Publication: Tales of Two Copyrights, Congrès Open in Order to Advance Science organisé par les Universités belges dans le cadre de la 10th International Open Acess Week (23 octobre 2017: Bruxelles, Bibliothèque Royale) Publication Non publié, 2017-10-2 Communication à un colloque
Canadian Federation of Library Associations, Secondary Publishing Rights and Open Access, 07.2023
M. Carroll, Complying With The National Institutes of Health Public Access Policy: Copyright Considerations and Options, (2008), available at: https://digitalcommons.wcl.american.edu/facsch_lawrev/340
R. Caso, Uno spettro si aggira per l’Europa (ma non per l’Italia): il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, in corso di pubblicazione, versione 1.0 – 31.03.2024, Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10900212
R. Caso, Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, “secondary publication right” ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, Trento LawTech Research Paper n. 56, 2023, in corso di pubblicazione su Rivista italiana di informatica e diritto, Anno 5 , fascicolo 1 (2023)
R. Caso, Diritto di ripubblicazione, AISA Dizionario della Scienza Aperta, 04.06.2022
R. Caso, G. Dore, M. Arisi, “Secondary Publication Right: Exploring Opportunities and Limitations”, reCreating Europe e LIBER workshop, 9 Dicembre 2021. Registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=2jRF6Mfmpwo. Slides: https://zenodo.org/record/5771593#.YvDbZfFBxUc
R. Caso, Il diritto d’autore accademico e la mercificazione della scienza, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, Cap. 23, p. 309
R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342
R. Caso, The academic copyright in the age of commodification of scientific research, in SCIRES-IT – SCIentific RESearch and Information Technology, Volume 10, Special Issue (2020) Open Science: New models of scientific communication and research evaluation, Issue edited by P. Gargiulo and Editors in-Chief V. Valzano and M. Cigola
R. Caso, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento LawTech Research Papers, nr. 37, Trento, Università degli studi di Trento, 2019, in Opinio Juris in Comparatione, v. 2019, n. 1/2019 (2019), p. 45-78
R. Caso, Il diritto d’autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento LawTech Research Papers, nr. 36, Trento, Università degli studi di Trento, 2018
R. Caso, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento LawTech Research Papers, nr. 35, Trento, Università degli studi di Trento, 2018, in I. De Gennaro, H. Hofmeister, R. Lüfter (eds.), Academic Freedom in the European Context. Legal, Philosophical and Institutional Perspectives, in Palgrave Critical University Studies book series (PCU), Springer Nature, 2022, 259-288
R. Caso, La legge italiana sull’accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche, Trento LawTech Research Papers, nr. 18, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014; in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, nr. 4/2013, pp. 681-702
R. Caso, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell’università italiana sull’Open Access [Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policyfor Italian universities], Trento LawTech Research Papers, nr. 16, Trento, Università degli Studi di Trento, 2013
Digital Republic (Ана Лазарова), The long-awaited amendments to the Bulgarian Copyright Act are a fact as of 01.12.2023, 01.12.2023
European Commission (written by C. Angelopulos), Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, 01.08.2022
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Improving access to and reuse of research results, publications and data for scientific purposes – Study to evaluate the effects of the EU copyright framework on research and the effects of potential interventions and to identify and present relevant provisions for research in EU data and digital legislation, with a focus on rights and obligations, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2777/633395
H. Gruttemeier, Le droit de publication secondaire – quelle valeur et quelles perspectives ?, Revue maghrébine de documentation et d’information, [S.l.], n. 25, p. 201-214, mars 2018. ISSN 1737-0744. Disponible à l’adresse : >http://www.revue-uma.rnu.tn/index.php/RMDI/article/view/104>
L. Guibault, Owning the Right to Open Up Access to Scientific Publications (January 3, 2011). OPEN CONTENT LICENSING: FROM THEORY TO PRACTICE, L. Guibault and C. Angelopoulos, ed., Amsterdam University Press, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1829889
L. Hood, Secondary publishing rights can improve public access to academic research, The Conversation, July 25, 2023
P. B. Hugenoltz, ALLEA Statement on Open Access Publication under “Big Deals” and the New Copyright Rules, Kluwer Copyright Blog, 12 Dec. 2022
IGSG (CNR), Right2Pub. Balancing Publication Right: la voce della comunità scientifica su “rights retention” e “secondary publishing right”, 30.09.2023
S. Khoo, The Plan S Rights Retention Strategy is an administrative and legal burden, not a sustainable open access solution, Insights – 34, 2021
S. Khoo, Why the Plan S Rights Retention Strategy Probably Won’t Work, The Scholarly Kitchen, Jul 27, 2021
K. Krapez, Secondary Publication Right of Scholarly Works: A Comparative Analysis of Regulations in Slovenia and the EU Member States, 76 PRAVNIK 585 (2021)
M.C., Janssens, Academic Publishing: Open Access as an Alternative Licensing Market for Academic Publishing and Scientific Communication (September 30, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4234371 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4234371
P.C. Langlais, Quand les articles scientifiques ont-ils cessé d’être des communs ?, Hypotheses, mars 11, 2015
A. Lazarova, Introducing a zero-embargo Secondary Publication Right in Bulgaria, 09.02.2024
F. Lorenzato, Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche, in R. Caso (a cura di), Pubblicazioni scientifiche, diritti d’autore e Open Access. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008,Università di Trento, Trento, 2009, p. 47
F. Majekolagbe, A Right to Republish: Redesigning Copyright Law for Research Works (October 3, 2023). Minnesota Journal of Law, Science & Technology, Vol. 25, No. 1, 2024, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4591844
C. Morrison, J. Secker, B. Vezina, J. Ignasi Labastida I, V. Proudman, (2020). Open Access: An Analysis of Publisher Copyright and Licensing Policies in Europe, 2020. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4046624
V. Moscon, Academic Freedom, Copyright, and Access to Scholarly Works: A Comparative Perspective (January 1, 2015). in Caso R., Giovanella F., Balancing copyright law in the digital age: some comparative perspectives, 2015, pub. Springer. ISBN 9783662446478 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2641116
A. Peukert, M. Sonnenberg, Copyright and Changing Systems of Scientific Communication, Chapter in the book The Future of Scholarly Publishing: Open Access and the Economics of Digitisation, 2017
N. Peifer, Regulatory Aspects of Open Access, 1 (2010) JIPITEC 131, https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-3-2010/2791
Plan S, Rights Retention Strategy
M.C. Pievatolo, Intervista alla Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo. Proprietà intellettuale o scienza aperta?, DIMT, 15 luglio 2022
M.C. Pievatolo, I custodi del sapere, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 31 maggio 2021
M.C. Pievatolo, Agorà o museo? Una proposta di legge per l’accesso aperto, Roars, 25 settembre 2018
M.C. Pievatolo, Il diritto d’autore preso sul serio: una legge per liberare la letteratura scientifica, Roars, 28 giugno 2016
E. Priest, Copyright and the Harvard Open Access Mandate, (2012) 10(7) Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 377
J. Reichman, R. Okediji, When Copyright Law and Science Collide: Empowering Digitally Integrated Research Methods on a Global Scale (2012) 96 Minnesota Law Review 1362-1480, available at: https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2675/
S. Rouah, R. D. Bourdon, Access to Scientific Works, Exclusive Rights and Free Science, “Revue internationale du droit d’auteur” (2019)
S. Shavell, Should Copyright of Academic Works be Abolished?, The Journal of Legal Analysis, Forthcoming, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 655, Harvard Public Law Working Paper No. 10-10, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1525667
K. Stockmar, T. Dreier, A. Geyer-Schulz, Legal Promotion of Open Access Archives and Possible Implications: The Proposal of the German Conference of Education Ministers, 2006
P. Suber, Author Rights and the Harvard Open Access Policies: a Response to Patrick Alexander (2021) 34 Insights 1
G. Tsakonas, K. Zoutsou, M. Perivolari, (2023). Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8428315
University of Zurich, Project to anchor a second publication right in Switzerland, 31.05.2023
D. Visser, The Open Access provision in Dutch copyright contract law, (2015) 10(11) JIPLP, 872
Policy e riferimenti normativi
AISA, Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore, 2016
AISA, Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico: testi normativi di riferimento
AISA, La proposta di legge Gallo
AIE, A.S. 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica. Nota dell’Associazione Italiana Editori
ALLEA, ALLEA Advocates for EU-Wide Secondary Publication Rights and Better Negotiation of Future “Big Deals”, 12 Dec. 2022
EU Commission, European Research Area Policy Agenda. Overview of actions for the period 2022-2024, 2021
Knowledge Rights 21, A Position Statement from Knowledge Rights 21 on Secondary Publishing Rights, 2022
LIBER, Secondary Publisher Right, v. 2, 2021
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recheche (Francia) – Ouvrire la Science, Mettre en œuvre la stratégie de non-cession des droits sur les publications scientifiques, Jullet 2022
Ministero dell’Università e della Ricerca (Italia), Piano nazionale della scienza aperta, p. 6
US bill, Fair Access to Science and Technology Research Act
US bill, Public Access to Public Science (PAPS) Act
Progetti di ricerca
reCreating Europe
Right to Research in International Copyright Law
Conferenze e seminari
19.12.2023, Il diritto alla ricerca. Nuove frontiere e profili evolutivi del diritto d’autore, ore 9-14 – Biblioteca Vallicelliana – Sala Borromini
Piazza della Chiesa Nuova 18, Roma
05.05.2023, “Copyright as a vehicle for access to science and culture: looking ahead”, LUISS, Roma (online)
reCreating Europe Final Conference – Brussels, 21st-22nd March 2023
Workshop on “An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures”, with Giulia Dore, 23 & 24 February 2023, Brussels and online meeting
Primo Convegno del gruppo di lavoro Open Science della CoPER, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 6-7 dicembre 2022
GDE 22: Open Science and Intellectual Property: the Dilemma, Fide Foundation and TIPSA (Transatlantic Intellectual Property Academy), Thu, 10 November 2022, 17:30 – 18:30 CET [online]
Copyright Evidence: Synthesis and Futures, University of Glasgow, Advanced Research Centre (ARC) 17-18 October 2022 [online]
AISA, Scienza aperta e società democratiche, 20-21.10.2022 (presentazioni qui)
“Un’esplosione di conoscenza: dalla teoria alla pratica per ridurre le disuguaglianze“, XI Convegno nazionale NILDE sul Document Delivery e la cooperazione interbibliotecaria, Sessione pomeridiana 14.30-17.30 – Discutendo di Open Science, Università di Messina, 28 settembre 2022
Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Istituto Italo-Cinese, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan (online), 19 May 2022
Academic Copyright. Open Access and the “Moral” Second Publication Right, “New Perspectives on Copyright”, LawTech Seminars, 28 aprile 2022, Università di Trento, Palazzo di Giurisprudenza, ore 14-17.00
Webinar — Secondary Publishing Right: Exploring Opportunities and Limitations, reCreanting Europe, 13.12.2021
Interviste
Scienza aperta: anche una questione di diritti d’autore, intervista di Roars a Roberto Caso, 4 maggio 2023
Roberto Caso: intervista per CLAKP su “Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico”